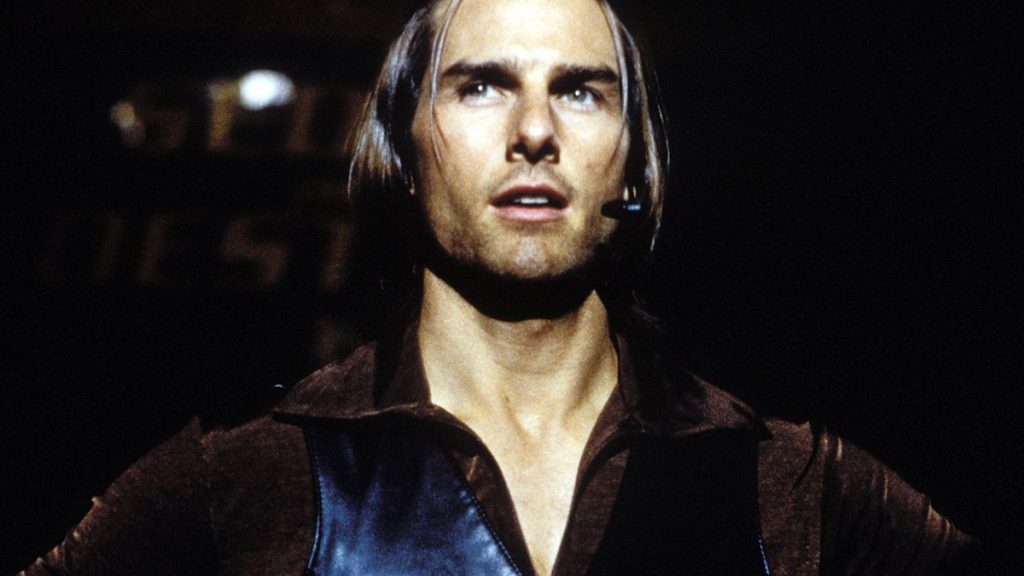La grande bellezza di Paolo Sorrentino (vincitore del Premio Oscar al miglior film straniero, quando ancora si chiamava così nel 2014), è uno dei suoi lungometraggi più acclamati e criticati allo stesso tempo.
Un film che mette al centro della narrazione il protagonista, scrittore, Jep Gambardella (Toni Servillo) ed il suo continuo disincanto nei confronti di tutto ciò che lo circonda.
Opera ermetica, che ha fatto di questa sua peculiarità la chiave di volta di questo immenso lavoro.
Ha destato non pochi turbamenti riuscendo a destabilizzare sapientemente il lato più torbido e profondo di molte coscienze.
Definirlo un’apologia di Roma suona errato e soprattutto riduttivo. La capitale c’è ed è presente in modo quasi irriverente in tutto il suo splendore ed imponente maestosità, ma la sua bellezza viene usata da Sorrentino, quasi come scudo di protezione dinnanzi allo squallore delle persone, la fauna, che la città è costretta a dover accogliere e a vegliare quotidianamente.
Roma è molto peggiorata.
In maniera verticale!
Un mondo fatto di nefandezze, false certezze e convinzioni inesistenti, che conducono tutte al ribrezzo dell’uomo miserabile e alla fatica del dover stare al mondo.
Il decadentismo della “realtà scadente”
L’idea del cinema, come salvezza dalla realtà scadente, era già fortemente presente nel film che ha portato la statuetta nelle mani del regista, per poi rimettersi al processo di transustanziazione totale, nell’Amarcord sorrentiniano, con: È stata la mano di Dio.
Ed è proprio nella realtà scadente che la grande bellezza inizia a porre le sue fondamenta.
Un’eco felliniana, della formula ASA NISI MASA, trova spazio attraverso una raffinata rielaborazione, con il numero di magia della giraffa, che scompare dinnanzi agli occhi di Jep Gambardella, incalzando, ancora una volta, su quanto l’esistenza sia solo un trucco, un’illusione, quel gioco di prestigio, che è in grado di salvare dall’inesauribile imbarazzo e dall’inadeguatezza del saper vivere.
È solo un trucco. Sì, è solo un trucco.
Il gioco di contrasti tra le statue di marmo freddo e la ricorrente fluidità dei corpi nudi, rispecchia in modo sublime l’artefatta perfezione dell’esteriorità, educata a celare il disagio interiore dell’essere umano e il costante ed opprimente senso di ansia, che tormenta donne e uomini nel non riuscire mai a sentirsi adatti a nulla.
Jep: “Non sono più adatto a questa vita, a questa città”.
Dadina: “Nessuno è adatto ad un cazzo, Jep”.
Gli sparuti e incostanti sprazzi di bellezza
«Finisce sempre così, con la morte, prima però c’è stata la vita». Nel monologo finale dello “scrittore dallo scatto breve”, è racchiusa l’essenza dell’intera opera. C’è la morte, ma c’è anche la vita. Quel palcoscenico della sopravvivenza dove non rimane altro che prendersi un po’ in giro, e far scorrere il tempo cercando di comprendere chi si è veramente e qual è l’esatto ruolo da ricoprire.
Chi sono io? e nel romanzo di Breton non c’è risposta. E nemmeno per nessuno di noi.
Ma nello scenario decadentista di Sorrentino, la speranza di una serenità temporanea esiste e si palesa nello sparuto ed incostante sprazzo di bellezza e nell’immaginazione percepibile dagli occhi di una Madame Ardant, sognante di essere realmente l’irresistibile femme d’à côté, o dal sorriso appena accennato di Jep Gambardella, che rievoca spudoratamente quello malinconico di Marcello Mastroianni nel gran finale della Dolce Vita.
Che cos’è una vibrazione? La rincorsa verso la società stereotipata
La grande bellezza si offre come specchio della società contemporanea, in cui lo stereotipo ed il luogo comune fanno da padroni.
Dove chirurghi plastici assumono le vesti di santoni e i cardinali decantano doti culinarie, ponendo in secondo piano la loro reale vocazione, ormai dimenticata.
Un contesto odierno nel quale, se non sei al contempo «madre e donna», non hai diritto di aver alcun tipo di salvacondotto e dignità. E dove millantatori dai poteri extra sensoriali immaginari, dando testate al muro, si ergono sul piedistallo degli artisti avanguardisti ed incompresi.
«Che cos’ è una vibrazione?». Ma l’artista, al giorno d’oggi, è colui che ha il diritto di poter rispondere con inetta fermezza: «Non lo so che cos’è una vibrazione».
La verità è che tutto questo chiacchiericcio, non rappresenta altro che fuffa impubblicabile; è il niente sedimentato sotto il bla bla bla…
La Santa. Le radici. E l’eterno ritorno del «Non ti disunire»
Nel caotico vortice della mondanità dello scrittore tormentato e costantemente alla ricerca della grande bellezza, irrompe “La Santa” (Giusi Merli).
Personaggio incantevolmente decentrato, al di fuori dei paradigmi imposti, che esorta a non separarsi mai dalle radici, «perché le radici sono importanti», di non affannarsi a diventare ciò che non si è, e di rimanere sempre fermi ai propri valori senza disperdersi, e disunirsi.
«Non ti disunire», inciterebbe l’Antonio Capuano dell’ultimo film del regista.
Ed è proprio dalle sue origini, da uno dei ricordi più reconditi e remoti della sua giovinezza, che Jep Gambardella trova nuovamente l’ispirazione per scrivere il nuovo romanzo. Dal ricordo di quella notte al faro, dove tutto, per lui, era ancora di rara ed incontaminata bellezza, e grazie al quale, riesce a dar vita a nuove prime parole.
Altrove c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio.