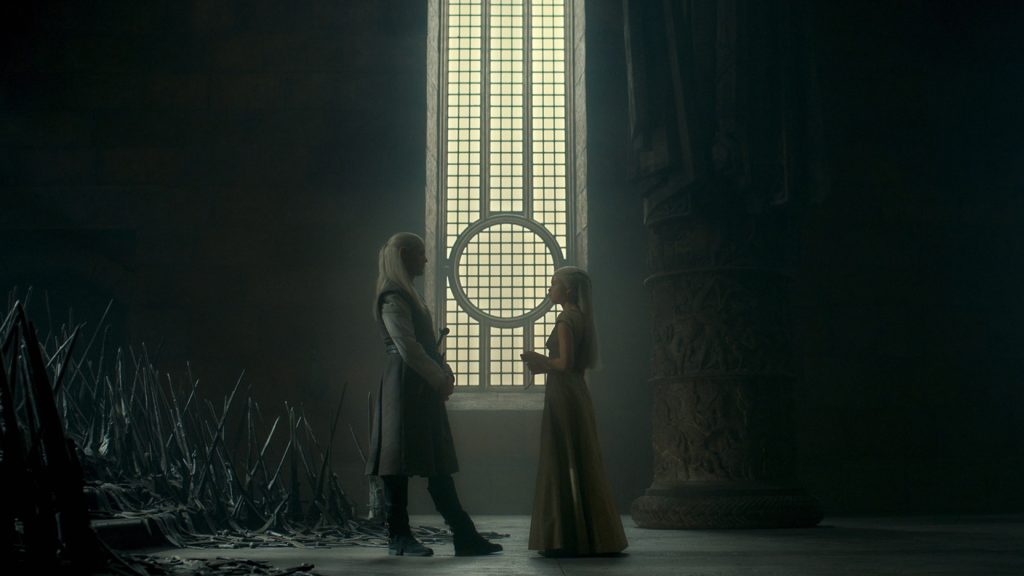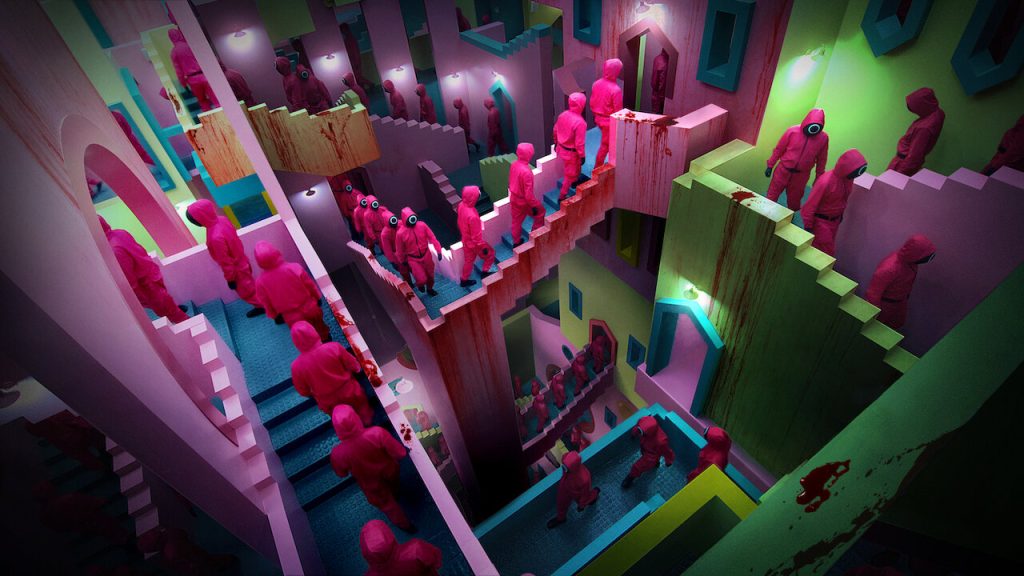Più di tutto questo, ciò che sorprende è questo nuovo genere di campagna dove si respira un’aria di solitudine urbana
Gianni Celati, da Verso la foce, Reportage per un amico fotografo, testo incluso nel catalogo della mostra Viaggio in Italia, 1984, a cura di Luigi Ghirri, Gianni Leone ed Enzo Velati con gli Appunti – Viaggio in Italia di Arturo Carlo Quintavalle
Nel novembre del 2008 si inaugurava a Ferrara, nell’acuminato Palazzo dei Diamanti, un’importante mostra di Joseph Mallord William Turner intitolata Turner e l’Italia che riuniva per la prima volta insieme le opere che il celebre paesaggista romantico aveva dedicato al Bel Paese. Il pittore della luce idealmente legato al paese della luce, l’Italia, aveva visitato l’Adriatico, meta insolita per un Grand Tour: verso Comacchio, Rimini e poi giù fino ad Ancona, per scivolare infine su Roma.
La luce di Turner si mostra negli sprazzi di colore più astratti e confusi. Volendola prendere come tramite per legarlo a Gianni Celati, ricorda anche la capacità di Luigi Ghirri di rarefare la parte più impalpabile e fissa dei paesaggi: l’immagine ultima, come la chiamava James Hillman. Quella che ferma l’azione e uccide la foga consumistica che trasforma l’immagine in merce. L’immagine che placa, che ottunde, che trasogna. L’immagine che assorbe – e restituisce – luce. Sarà Luigi Ghirri a invitare l’amico Celati a corredare di un suo scritto il catalogo della mostra Viaggio in Italia, seminale lavoro del 1984 che rifonderà la fotografia di paesaggio (e di viaggio) italiana.
Questione di sguardo
Gianni Celati (1937 – 2022) figura poliedrica di artista dedito a tutto quello che è minore (come a fine Settecento era considerata minore la pittura di paesaggi e in parte lo è ancora) come scrittore, come docente, come critico, come narrattore, come regista (e in un certo senso anche come traduttore), è stato omaggiato alla passata edizione del Biografilm Festival di Bologna (10-20 giugno 2022) con una retrospettiva dei suoi lavori da documentarista e i lavori registici di cui è stato narrattore, più alcuni frammenti filmici rari e inediti. Verrà inoltre nuovamente omaggiato ad ottobre nella rassegna, sempre bolognese, Archivio Aperto, che si occupa principalmente di riscoprire patrimoni cinematografici inediti tra filmati amatoriali, privati e sperimentali, valori descrittivi perfetti per le opere di Celati.
La rassegna è per altro organizzata da Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia che ne era ente amico. Celati, prototipo del viaggiatore residente, era infatti di casa a Bologna, dove ha insegnato per anni letteratura inglese alla facoltà del Dams, così come a Ferrara (dov’era nata sua madre), a Sondrio (dov’era nato lui) e a Scandiano di Reggio Emilia (dov’era nato l’amico Ghirri): tutti posti fuori mano e sperduti, meglio se in pianura, lungo la Strada provinciale delle anime.
In questo viaggio che abbiamo fatto non abbiamo visto nulla di speciale, però non mi è dispiaciuto. Abbiamo visto tanti posti, e dappertutto ci sono tante case come qui, e dappertutto c’è tanta gente come noi
Strada provinciale delle anime di e con Gianni Celati, 1991
Strada provinciale delle anime è il primo film documentario di Gianni Celati dopo gli esperimenti girati nel ‘77 coi suoi studenti del Dams ed è il resoconto filmico di un viaggio organizzato “alternativo” perché il pullman di trenta turisti – tra cui parenti, amici, e compatrioti ferraresi, scandianesi e roncocesiesi di Celati (e Ghirri che fotograferà tutto) non viaggerà che per visitare i paesini e i paesaggi spopolati lungo la foce a delta del Po.
La strada provinciale (attributo che viene usato per definire la gente semplice, ma che a livello topografico – per il codice della strada – indica quelle strade gestite dalle province o dalle città metropolitane) delle anime esiste davvero, ma “non porta a un cimitero” come supponeva sconsolato un amico turista di Ghirri. Viaggia lungo la nebbia e i reticoli di campi e cemento, e smog e diserbanti, e gente, del Po. E non porta da nessuna parte.
Più dell’inquinamento del Po, degli alberi malati, delle puzze industriali, dello stato di abbandono in cui volge tutto quanto non ha a che fare con il profitto, e infine d’un’edilizia fatta per domiciliati intercambiabili, senza patria né destinazione – più di tutto questo, ciò che sorprende è questo nuovo genere di campagne dove si respira un’aria di solitudine urbana
«Alla fine del viaggio c’era uno che si era ammalato, uno che si era innamorato, e uno che non voleva più tornare a casa. Allora siamo finiti in quella villa là […]. Di popolazioni invisibili l’una all’altra». Dice Celati, a inizio film, che ha percorso queste strade messe come a triangolo – seguendo il disegno del delta, delimitato dal mare – e illuminate dalla provinciale delle anime, durante l’inverno, ma voleva ripercorrerle in estate, con altre persone. E il documentario è il resoconto di questo viaggio estivo, non più in solitaria, ma “con altre persone”.
Un posto definitivo dove riposarsi – Spazio diffuso in ogni direzione
Il mondo di Luigi Ghirri di Gianni Celati, 1997, secondo lungometraggio di Gianni Celati è dedicato (come il primo) a Luigi Ghirri, l’amico scomparso improvvisamente nel 1992 poco dopo il completamento di Strada provinciale delle anime.
Il terzo lungometraggio di Gianni Celati è Case sparse. Visioni di case che crollano (2002), narrato dal critico d’arte inglese John Berger (1926-2017) che per decenni ha vissuto in un borgo sperduto sulle Alpi svizzere. Mi chiedo se forse il discrimine per capire se un posto è interessante è la percentuale di case vuote che possiede.
Ghirri, Celati, Berger e tutta la loro cerchia di viaggiatori residenti, viaggiatori immoderni.
Celati viveva da anni a Brighton, nel sud dell’Inghilterra, un’altra pianura vicino a un’altra costa, reticolato di un’altra megalopoli urbana, Londra.
Le opere di Celati, così come di tutti questi immoderni narratori di pianure come Ghirri, Cavazzoni, Benati, Sironi, lo scandianese Matteo Maria Boiardo o narratori di sguardi di pianura come John Berger, si mescolano all’altezza del 45° parallelo, che lega la Pianura Padana alla Mongolia. Chi conosce quantomeno la prima di esse sa che è popolata di persone genericamente definite “indiane” con una bonarietà dopotutto non razzista, che dicono di essersi trasferite qui perché “c’è lo stesso clima che da noi”, trovandosi entrambe intorno al 45° parallelo.
Il 45° parallelo
Sul 45° parallelo (1997) è il titolo del primo lungometraggio di Davide Ferrario di cui Gianni Celati è narrattore, sceneggiatore e protagonista, presentato anch’esso allo scorso Biografilm Festival. Protagonisti, insieme a Celati, altri viaggiatori immoderni come lui e come Ferrario con la sua troupe: Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, voce e chitarra del gruppo di “punk emiliano” CCCP che all’epoca del viaggio, per motivi strettamente storici, erano già CSI.
Una sua troupe li seguiva mentre Ferrario girava a Torino, con musiche dei CCCP e protagonista Valerio Mastandrea, Tutti giù per terra, dal romanzo di Giuseppe Culicchia, storia di un’altra solitudine urbana. Un reticolo di relazioni, amicizie, persone, cose, strade, tende, case. Tabula rasa elettrificata era l’album in questione dei CSI che contiene il brano Anime fiammeggianti, titolo di un film di Ferrario del 1994 con protagonista un altro narrattore solitario, Giuseppe Cederna.
E Ferrario intanto si sdoppiava tra Torino, una Mongolia virtuale e l’Emilia dove girava con Celati, che a differenza di Zamboni e Ferretti non era partito per la Mongolia (per una volta) ma era rimasto lì. Virtualmente è insieme a Giorgio Canali, seconda chitarra della band, annoiatissimo all’idea del viaggio: preferisce sorseggiare un drink ammollato in una piscina gonfiabile nel giardino della sua villa in rovina.
Reticolati di persone e di scelte.
Mondonuovo
Mondonuovo (2003) – dal nome di una frazione della provincia bolognese – è il secondo lungometraggio che Davide Ferrario compone a partire dalla vita, dalle parole e dai gusti di Gianni Celati.
Celati narra il suo paese d’elezione, ripercorrendo i luoghi dove abitava la madre. Lo stile è il suo, nelle inquadrature, nel ritmo, nella pacata e ironica curiosità di indagare questo niente. E così ci si domanda: forse che Davide Ferrario ha girato Mondonuovo come lo avrebbe girato Celati? Certo, la narrazione filmica di Celati ha il grande pregio di non cambiare, forse persino di non evolvere, mentre Ferrario, da regista molto più prolifico, ha usato registri stilistici diversissimi tra loro e si è mosso agilmente tra finzione, documentario e film di montaggio.
In Mondonuovo come in Sul 45° parallelo si scorge una naturale convergenza su questo stile narrativo “emiliano” che anche Ferrario, nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, utilizza da fautore, e in parte forse da vittima: come se certi luoghi potessero narrarsi solo così, o, come fa dire lui stesso in Dopo Mezzanotte (2004), a uno dei suoi personaggi: «forse sono i luoghi che raccontano le storie nel modo giusto». Battuta che assume maggior peso considerando anche che il film è girato all’interno del Museo del Cinema di Torino.
Questa convergenza emiliana che costringe a una narrazione celatiana, dilatata e cadenzata (musicalmente un liscio, anche se Celati non li usa quasi mai), inerziale, costante, come di qualcosa che deve muoversi lungo strade di pianura, senza l’attrito della salita, senza l’impeto della discesa, senza la costrizione di entrambe.
Anche in Mondonuovo ci si muove lungo il 45° parallelo che riaffiora come benevola ossessione quando si attraversa un altro territorio che ne è delimitato, come nella Romania de La strada di Levi (2005), documentario in cui Ferrario ripercorre i luoghi del ritorno a casa di Primo Levi da Auschwitz, narrati dallo scrittore ne La tregua.
Vediamo pianure inframezzate da brutte case e da brutte fabbriche, in uno squallore depresso (sotto il livello del mare) e asfissiante.
Lo scenario desolante, grigio, nebbioso del 45° parallelo diviene quello delle imprese italiane delocalizzate in Romania perché – dice il manager italiano esule o predatore: «nuovo millennio [vuol dire] nuovo orizzonte» ma l’orizzonte è pressoché invisibile, carico com’è di fumate tossiche possibili grazie a una pesante deregulation made in ex Urss. Americanizzazione totale.
La Romania come la Pianura Padana è costellata di campi coltivati e di petrolchimici.
E le schitarrate pesanti dei CSI sono molto meno rizomatiche e liberatorie delle urla mischiate alle batterie elettroniche dei CCCP. Segno dei tempi.
Questo paesaggio ti fa sentire quanto è ristretto un orizzonte, ogni orizzonte
Diol Kadd, 2007
L’ultimo documentario di Gianni Celati è l’unico a sfuggire, geograficamente, a questa narrazione padana e alla convergenza sul 45° parallelo.
Girato lungo l’arco di sette anni durante i tre lunghi soggiorni dello scrittore, con la sua troupe di professionisti-amici, nel villaggio senegalese di Diol Kadd. Poco distante in linea d’aria (qualche dozzina di chilometri) dalla moderna capitale di Dakar eppure già quel che basta per erigere un muro di rifrazione al tentativo di omologazione bianca sulla cultura tradizionale locale e al tentativo di impossessarsi dell’anima di un luogo per sostituirla con un manipolo di crimini e di scontrini.
Non è casuale l’utilizzo di un termine come anima, perché sembra che per tutto il documentario – il più lungo girato da Celati, un’ora e mezzo abbondante – l’autore non faccia che osservarla e parlarle.
Lo sguardo filmico del narrattore indugia sui corpi e sui volti degli e soprattutto delle abitanti del villaggio, seguendone le azioni quotidiane, cercando di coglierne, senza rubarle, le qualità intime in un dialogo costante con la macchina da presa, con lo spettatore, con sé, con la troupe, con le narrattrici protagoniste.
Celati è a Diol Kaad ospite di Moussaka, un illuminato predicatore coranico/artista girovago, e dell’attore Mandiaye N’Diaye (1968-2014) che dal Teatro delle Albe ravennate torna con lui nel paese natale senegalese.
Il film si ricompone poi in un montaggio fragile ma con una struttura chiaramente rivolta verso un finale a partire dal lungo girato e dagli appunti che Celati ha preso durante i soggiorni e che diventeranno anche un libro, Passar la vita a Diol Kaad, Diari 2003-2006. Diol Kaad è probabilmente il film più positivo di Celati che mantiene il suo sguardo indolentemente estatico ma è forse caricato da una dose maggiore di meraviglia.
Bellissime le sequenze che partecipano agli spettacoli del villaggio: le danze erotiche e frenetiche delle donne (quando Celati si accorge che «volevano soprattutto ballare»), le teatralizzazioni di Moussaka, fino al rave che un dj di Dakar imbastisce grazie a un muro di casse acustiche degne di un club riminese ma di cui Celati impedisce di sentire il prodotto, sostituito invece da tamburi tradizionali e vociare. Scelte stilistiche.
Del resto le musiche di Celati sono estremamente pacate: moltissimo Bach e in Diol Kaad la musica è sempre tramite con l’anima, col divino, col sacro: anche le partiture vocali della mistica bassomedievale Ildegarda di Bingen, di cui occorrerebbe riprendere le parole, a chiusa di questo lungo excursus. Invece lasceremo spazio a un padano silenzio.
Dove vivo ora, su 25 case circa, almeno 20 sono disabitate.
E a Diol Kaad Moussaka mette in scena lo spopolamento: i vecchi muoiono, i giovani emigrano. Cosa resta?“
Il mondo ci sembra avanzare verso qualche rovina e noi ci limitiamo a sperare che l’avanzata sia lenta.”
Segui FRAMED su Instagram e Facebook. C’è anche il canale Telegram aggiornato quotidianamente.