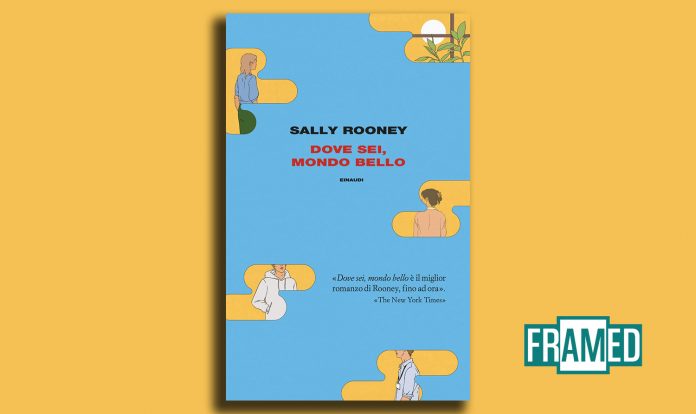Bridgerton, il perfetto binge-watching
Dopo un accordo da 150 milioni, il debutto di Shondaland su Netflix si preannunciava strabiliante, e così è stato con Bridgerton, serie rilasciata il 25 dicembre 2021. Anche se pochi avrebbero potuto immaginare l’immediato fenomeno creatosi intorno a questa serie. Io stessa sono caduta vittima del binge-watching, divorandola in poco più di un giorno. Ho provato quindi a stilare un elenco delle peculiarità che hanno catturato, per varie ragioni, la mia attenzione.
1 – STORIE ROMANTICHE SEMPREVERDI
Showrunner della serie è Chris Van Dusen, pupillo di Shonda Rhimes già dai tempi di Grey’s Anatomy. Il soggetto originale, tuttavia, è tratto dalla serie di romanzi rosa di Julia Quinn, inaugurata con The Duke & I, nel 2000. Questo implica che non manca di certo il materiale per altre (numerose) stagioni, ma soprattutto sottintende un concetto-chiave per comprendere il successo di Bridgerton: l’escapismo. Parte essenziale dei romanzi rosa è infatti l’immaginazione di una realtà che soddisfi maggiormente i nostri bisogni emotivi e affettivi.
Una sorta di compensazione, anche banale, che in alcuni casi diventa un cosiddetto (purtroppo) guilty pleasure, un piacere da cui siamo noi stessi un po’ imbarazzati ma a cui non vogliamo rinunciare. Bridgerton funziona più o meno così. Ci saranno decine di momenti in cui vi chiederete: ma cosa sto guardando? Senza mai però riuscire a staccare gli occhi dallo schermo. Qui l’evasione dalla realtà riesce benissimo, catapultando lo spettatore in una surreale Londra della Reggenza (1813), tra balli, corteggiamenti e pene d’amore.
2 – AGGANCI A PERSONAGGI DELLA NOSTRA MEMORIA
Potremmo quasi mettere in parallelo il cognome dei Bridgerton a quello dei Bennet, poiché sì, appena si nomina la stagione dei balli il mio primo pensiero va a Orgoglio e Pregiudizio. E non solo il mio, in realtà. Chiunque abbia visto anche solo il trailer della serie ha immediatamente colto l’associazione con le atmosfere del romanzo di Jane Austen, pubblicato proprio nel 1813. Sfortunatamente qui però non c’è nemmeno l’ombra di Elizabeth Bennet, il cui spirito, forse, dovrebbe risiedere nella quasi omonima Eloise, sorella minore della protagonista Daphne. Ma parlerò in seguito dei personaggi femminili. Il vero aggancio del pubblico, infatti, avviene attraverso la particolare familiarità con il Duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page.

Misterioso, solitario, orgoglioso, superbo e sprezzante nei confronti della compagnia femminile. C’è bisogno di dirlo? È Mr. Darcy. Quel subdolo e meraviglioso archetipo di cui tutti, almeno una volta nella vita, ci innamoriamo. A guardarlo bene, però, non è solo Mr. Darcy, almeno non per noi ragazze/i cresciute/i negli anni 2000. Se diamo fondo, infatti, a un po’ di psicologia freudiana-edipica spicciola e un po’ di cultura pop, ecco che Mr. Darcy diventa Chuck Bass. E non è un caso, in quanto l’altro grande riferimento di Bridgerton, oltre a Jane Austen, è proprio la nostra sola e unica fonte sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan. Gossip Girl. Qui nelle sembianze di Lady Whisteldown (e con la voce di Julie Andrews). Serve davvero altro per catturare l’attenzione di un’intera generazione che ha vissuto nell’era di GG?
3 – OLTRE L’ORGOGLIO E IL PREGIUDIZIO: IL SESSO
Non giriamoci intorno, in Bridgerton c’è tanto sesso. Tanto che lo stesso showrunner ha affermato che se questa prima stagione avesse un sottotitolo sarebbe L’educazione sessuale di Daphne Bridgerton. Nel nostro immaginario spesso escludiamo la fisicità dai racconti in costume. Vediamo fanciulle vergini e caste aspettare con trepidazione il matrimonio. E Bridgerton ci suggerisce: ma cosa aspettavano se non la libertà di togliersi di dosso il peso della verginità e iniziare a vivere? Solo le donne sposate, infatti, potevano avere una vita sociale, ma se esistono innumerevoli opere sull’innamoramento e il corteggiamento, raramente vediamo cosa accade dopo.
In Bridgerton al contrario, gran parte degli sviluppi centrali della trama ruota attorno ai rapporti tra Daphne e il Duca. Anzi, proprio a questo proposito solleva un grande e inatteso problema sui limiti del consenso. C’è un particolare passaggio del romanzo, infatti, che gli autori della serie hanno deciso di “ammorbidire”, mantenendolo però centrale alla trama. Non voglio fare spoiler, ma se avete visto la serie sapete benissimo che quella scena non rispecchia decisamente la sensibilità contemporanea riguardo il consenso, che sia maschile o femminile. (E sicuramente si poteva gestire la scena incriminata in modo molto diverso).
4 – L’OSTENTATA MODERNIZZAZIONE
Durante il primo ballo, che apre la serie e presenta i personaggi, la canzone che sentiamo in sottofondo è una rivisitazione di thank u, next di Ariana Grande. La quintessenza del pop contemporaneo rielaborata da antichi quartetti d’archi. E nel corso degli episodi non è l’unica musica da Generazione Z che ascoltiamo. È possibile riconoscere anche Girls Like You (Maroon 5), In My Blood (Shawn Mendes), bad guy (Billie Eilish), Strange (Celeste) e Wildest Dreams (Taylor Swift). Questo detta già il tono di Bridgerton: è una serie creata per attrarre un pubblico giovane, che nel period drama desidera anche rivedere qualcosa di sé.
Il gusto per le scenografie, i colori, i costumi e le acconciature, infatti, è più vicino alla contemporaneità che all’epoca storica di riferimento. Si può dire anzi con certezza che non vi sia particolare ricercatezza e accuratezza storica nei dettagli. Al di là, comunque, dell’eccellente lavoro di fino di tutti gli artisti coinvolti nella realizzazione della serie. Ben 7500 abiti, per esempio, e ognuno che attrae inevitabilmente lo sguardo.

Abbastanza moderna è anche la generale visione del sesso (al di là di quell’unica scena che come già detto crea inevitabili controversie), soprattutto dal punto di vista femminile. Mancano quasi totalmente, tuttavia, riferimenti all’intero spettro della sessualità, a parte l’aspetto etero, cosa che per Shondaland è un po’ inusuale. Forse ci sarà modo di conoscere meglio altri personaggi, qui solo accennati, nelle prossime (eventuali) stagioni.
5 – L’ANACRONISTICA AGENCY DEI PERSONAGGI FEMMINILI
Per agency intendo qualcosa di non perfettamente traducibile in italiano. È una caratteristica dei personaggi che muovono l’azione e rifiutano la passività. Si può definire in un certo senso come la libertà di agire nel mondo narrato e per questo è così inusuale in un period drama. Siamo abituati a pensare alle narrazioni in costume come dei momenti in cui il peso femminile nella società è piuttosto irrisorio. In Bridgerton si percepisce continuamente invece l’attrito fra la visione maschile e quella femminile del mondo. C’è spirito, arguzia e ironia ma c’è anche una buona dose di risentimento, amarezza e rabbia verso gli obblighi sociali delle donne e le aspettative nei loro confronti, nell’Ottocento come oggi. Qualcuno ha parlato di sottotesto femminista, ma non è abbastanza approfondito per ritenerlo pienamente tale. Diciamo che gratta piuttosto la superficie delle cose in quella direzione.
6 – L’AZZARDO DEL COLOR-BLIND CASTING
Veniamo al punto che aspettavo di più, ovvero la prima cosa che ho notato già dal trailer: il blind casting! Le produzioni di Shonda Rhimes vanno da un estremo all’altro, in questo senso. Se guardiamo Le regole del delitto perfetto, parte essenziale dello show è la blackness della sua protagonista, Annalise Keating/Viola Davis. Se invece andiamo a osservare con attenzione i personaggi di Grey’s Anatomy, scopriamo che nessuno è caratterizzato appieno culturalmente, per lasciare la possibilità a qualsiasi interprete di avere il ruolo, indipendentemente dall’etnia d’origine. Questo è il blind casting, che spesso collima con la più spinosa questione della color blindness. Quando si afferma cioè di non vedere nessun colore, si annulla automaticamente parte dell’identità delle persone non caucasiche, rischiando di essere ugualmente razzisti.

In Bridgerton gli autori però compiono un azzardo molto apprezzato, facendo leva su un verosimile falso storico. Alcuni storici sono infatti convinti che la regina Charlotte, moglie di Re Giorgio III, fosse lontana discendente di una famiglia portoghese nera. I ritratti della Regina possiamo vederli semplicemente digitando il suo nome su Google, ma il punto è che Bridgerton ci propone l’utopia che quest’ipotesi implica. Ossia come sarebbe la società se già due secoli fa avessimo liberato davvero i popoli colonizzati, lasciando che ricoprissero anche ruoli di potere.
Purtroppo questo aspetto cruciale è vagamente accennato in modo esplicito ma mai scavato fino in fondo. Approfondirlo significherebbe far virare la storia verso un aspetto propriamente politico, cosa che Bridgerton non intende fare. Rimane una storia d’amore. Di per sé però è già una rivoluzione vedere, per esempio, l’affascinante Duca di Hastings interpretato da un anglo-zimbabwese. La sua bellezza non è un feticcio, è una dichiarazione: il principe azzurro può essere diverso da come lo abbiamo sempre immaginato e così può essere tutta la nostra percezione della realtà.
7- REGÉ-JEAN PAGE (E L’OTTIMO CAST)
Rimango in tema con il Duca di Hastings, perché il lavoro compiuto da Regé-Jean Page con il suo personaggio è forse la prima ragione in assoluto del binge watching. È inutile negarlo, sappiamo fin dall’inizio come andrà a finire tra il Duca e Daphne, vogliamo solo vedere come il Duca arriverà alla conclusione del suo arco. Parlo dal punto di vista più inflazionato, ma il percorso di mutamento del personaggio maschile è di solito ciò che più attrae le donne (generalmente etero) in una storia d’amore.
Nel percorso del nostro Duca, ma chiamiamolo Simon, è fondamentale, per esempio la meravigliosa Lady Danbury (Adjoa Andoh): donna risoluta e piuttosto incurante delle convenzioni. Veramente libera.
Tra un ballo e l’altro abbiamo poi l’occasione di conoscere la regina Charlotte di Golda Rosheuvel (star del West End londinese). Anche lei, come Lady Danbury è un personaggio creato su misura per fare la differenza e dettare un nuovo modo di rappresentare le donne nere.

Infine, nella costellazione di interpreti di questo cast ricchissimo (solo i Bridgerton sono otto tra fratelli e sorelle), concludo con Nicola Coughlan. Chiunque abbia visto Derry Girls (serie consigliatissima, sempre su Netflix) probabilmente ne è rimasto colpito già da tempo. La bontà, la dolcezza e la forza del suo personaggio (Penelope) è un altro punto di forza di Bridgerton. E il legame che è in grado di creare con lo spettatore in questa prima stagione è a dir poco essenziale per tutte quelle a venire. Ovviamente se l’avete visto fino alla fine sapete a cosa mi riferisco.
In conclusione, Bridgerton non racconta nulla di nuovo o imprevedibile. Gran parte dei colpi di scena si intravedono già da molto lontano. In questo senso di sicurezza del già noto e di voluta e ricercata banalità, sta la sua perfezione. Shonda Rhimes ci ha fregati ancora una volta.
Continua a seguire FRAMED anche su Facebook e Instagram.